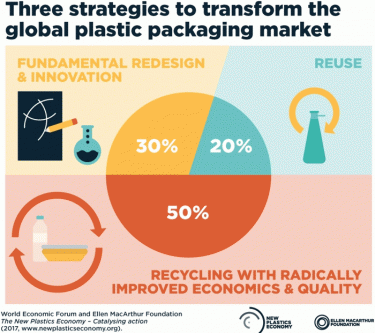Da imballaggi riciclabili a imballaggi riciclati il passo è lungo
Sempre più aziende annunciano di voler rendere il proprio packaging riciclabile, riusabile o compostabile al 2025. La tendenza è quella di puntare soprattutto al riciclo. Ma per raggiungere gli obiettivi di riciclo europei la riciclabilità sulla carta non sarà sufficiente.
Continuano ad aggiungersi nuove aziende e associazioni di categoria al fronte industriale che, dallo scorso anno, sta rendendo note le misure che verranno intraprese per ridurre l’impatto e le quantità di plastica utilizzata negli imballaggi. Le prime aziende che hanno annunciato impegni in tal senso su base volontaria, sono state noti brand che partecipano al programma The New Plastics Economy della Fondazione Ellen McArthur. Alcuni di loro, come Unilever hanno anche collaborato alla stesura del Piano di azione “NPE: Catalysing Action” del 2017 che ha ispirato molte delle misure annunciate.
L’impegno di massima che accomuna le aziende che si sono espresse ad oggi, consiste nel rendere tutti gli imballaggi utilizzati riciclabili, riusabili o compostabili al 2025. Altri impegni annunciati , prevalentemente correlati all’obiettivo riciclo, prevedono di utilizzare plastica riciclata negli imballaggi in percentuali che vanno da un minimo del 25%, passando per il 50% di Coca Cola per arrivare al 100% (come Evian e Werner & Mertz ) e di contribuire alla creazione di un mercato di sbocco per il granulo da riciclo.
Le aziende stanno lavorando al perseguimento degli impegni annunciati a livello europeo e internazionale senza avere ancora ben chiaro come arrivarci. L’impresa si preannuncia tutt’altro che facile alla luce dei contesti profondamente diversi dei vari mercati in cui le aziende operano che riguarda anche i sistemi di gestione rifiuti.
Nei programmi di multinazionali come Coca Cola (World Without Waste) , P&G (Ambition 2030), Unilever e Nestlè si accenna alla volontà di contribuire ad un miglioramento dei sistemi di raccolta rifiuti e soprattutto in quei paesi maggiormente responsabili della dispersione in mare dei rifiuti marini. Mancano però, anche in quelle sedi, indicazioni circa dove e come andare a farlo e soprattutto con quale ordine di investimenti.
Tra le azioni svelate alle quali le aziende stanno lavorando ce ne sono alcune che mi lasciano un pò perplessa perché rivelano la mancanza di una visione olistica e quindi di una progettazione sistemica.
Un esempio che chiarisce cosa intendo è quello di Unilever che, per risolvere le criticità collegate al fine vita dei sachet: confezioni monodose di detergenti in multimateriale (facilmente dispersi nell’ambiente), ha deciso di investire in una nuova tecnologia di riciclo denominata CreaSolv Process technology. Tale tecnologia verrà testata in un impianto pilota in Indonesia, uno dei cinque paesi che, con 1.300 tonnellate di rifiuti scaricati in mare ogni anno, contribuisce ad alimentare il marine litter.
Questa scelta, oltre ad essere un esempio su come le aziende tendano in genere a scavalcare azioni prioritarie della gerarchia dei rifiuti EU come prevenzione e riuso, solleva una serie di inevitabili domande che elenco. Ammesso che Unilever possa aprire degli impianti di riciclo basati su questa tecnologia nei paesi dove commercializza i sachet, come pensa la multinazionale di intercettare questi piccoli rifiuti senza un incentivo economico per chi li conferisce, e in mancanza di infrastrutture logistiche capillarmente diffuse sul territorio per gestire i flussi raccolti ? Chi dovrebbe sviluppare, progettare e gestire l’avvio a riciclo di questo flusso di rifiuti e sostenerne i costi ? Come fare in modo che siano disponibili le quantità necessarie per alimentare regolarmente gli impianti di riciclo e raggiungere economie di scala?
E infine, anche ammesso che si possano venire a creare questi presupposti, quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico complessivo di questa scelta comparato con opzioni alternative di fornitura per piccole dosi di prodotto che potrebbero essere messe in campo ?
 Se fossi un decisore politico in uno dei paesi che non hanno infrastrutture di raccolta rifiuti chiederei alle aziende di presentare progetti di responsabilità estesa del produttore da loro finanziati capaci di intercettare il 90% dei sachet ( o altri imballaggi problematici) immessi al commercio , oppure di creare delle refill station dove le persone acquistano la quantità di prodotto che possono permettersi di pagare. In alternativa promuoverei la vendita di prodotti per la detergenza in barrette solide e saponi.
Se fossi un decisore politico in uno dei paesi che non hanno infrastrutture di raccolta rifiuti chiederei alle aziende di presentare progetti di responsabilità estesa del produttore da loro finanziati capaci di intercettare il 90% dei sachet ( o altri imballaggi problematici) immessi al commercio , oppure di creare delle refill station dove le persone acquistano la quantità di prodotto che possono permettersi di pagare. In alternativa promuoverei la vendita di prodotti per la detergenza in barrette solide e saponi.
Queste misure di prevenzione dei rifiuti sarebbero anche indicate per aree isolate collinari o montane oppure per isole che non dispongono di impianti di trattamento rifiuti di prossimità con conseguente aggravio dei costi di avvio a riciclo da sostenere.
Un’altra misura annunciata dalle aziende che mi lascia perplessa è quella di sostituire la plastica con altri materiali sempre usa e getta, dalla carta alle bioplastiche, senza una visione sistemica sugli impatti ambientali ed economici e sulle conseguenze che i nuovi materiali avrebbero sui sistemi di avvio a riciclo già esistenti.
Anche nei casi in cui le aziende si basano su studi LCA per “giustificare” determinate scelte va detto che, come molti esperti di LCA concordano, le valutazioni LCA e EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) commissionate e diffuse dalle aziende sono “incomplete” perché spesso non considerano gli impatti ed effetti collaterali della fase di fine vita che variano a seconda del contesto geografico. Cosi come non considerano altre esternalità correlate a tutto il ciclo di vita di un bene che sono difficili da misurare e quantificare come il marine litter, la deforestazione, il cambiamento di uso indiretto del suolo (Iulc), ecc..
Anche in Italia per quanto riguarda oltre il 50% di imballaggi di plastica che vengono raccolti per essere termovalorizzati non sarà sufficiente che le aziende mantengano le promesse di riciclabilità tecnica del packaging perché il nodo da risolvere è quello della sostenibilità economica della filiera di riciclo. Ecco perché il piano Catalysing Action identifica tre strategie, ognuna rivolta a specifici flussi di imballaggi che non vengono riciclati che sono: riprogettazione, riuso e riciclo. Le azioni ad oggi rese note dalle aziende sono sbilanciate a favore del riciclo come ho commentato in un post dal titolo “Imballaggi: il riciclo per la plastica (ed altri materiali) da solo non basta”.
Quale delle tre strategie applicare per fare arrivare un bene al suo pubblico è una scelta che l’industria deve prendere sulla base delle caratteristiche dei sistemi post consumo dei mercati dove immette imballaggi. Questo implica per l’industria ammettere ed accettare che in un pianeta dai limiti fisici l’applicazione del modus operandi “one solution fits all “ tipica del modello economico globalizzato non “funge più” ma porta a ripetere gli stessi errori.
Per creare un mercato circolare per le plastiche, oltre all’adozione dei principi dell’ecodesign tra cui una standarizzazione dei formati e del design degli imballaggi, c’è una condizione essenziale da soddisfare che consiste nel convergere verso pochissimi polimeri per rendere più semplice la differenziazione da parte degli utenti, la selezione e il riciclo. Solamente così raggiungeremo flussi di ottima qualità e nelle quantità necessarie perché il riciclo sia economicamente sostenibile.
Se, ad esempio, decidessimo di convergere sul PET per realizzare vassoietti e contenitori vari il cui consumo aumenta con tendenze in atto, come un maggiore consumo di alimenti già pronti per l’uso, eviteremo che vengano raccolti e selezionati per essere bruciati e alimenteremo il mercato del r-Pet.
Capisco che questa decisione possa fare imbufalire l’industria dei polimeri che verrebbero esclusi, che dovrebbero trovare sbocchi alternativi alla produzione usa e getta, ma cosa possiamo fare per ridurre il consumo di risorse e allontanare gli effetti del riscaldamento climatico se non fare di più con meno?
Purtroppo ogni misura ambientale incontra alzate di scudi sia da parte di coloro che rifiutano il cambiamento sia di chi difende interessi di bottega, con l’esito che “si continua a ballare sul Titanic” pensando che il naufragio arriverà dopo di noi.
Come commentatori ben più autorevoli di me rimarcano la colpa del’inazione sul clima è condivisa tra le aziende che si limitano a fare azioni di facciata (come sostituire il materiale delle cannucce), i cittadini che non sono pronti a cambiare stili di vita e la politica, spesso appiattita sul corto-termismo, che non sa governare i processi e mediare tra i diversi interessi.
Prima parte. Segue una seconda parte dedicata agli impegni resi noti dall’industria delle bevande in relazione ad uno studio uscito in Inghilterra.
Silvia Ricci
Pubblicato sul blog di Silvia Ricci di Polimerica.it
Immagine in evidenza : Jessica den Hartog